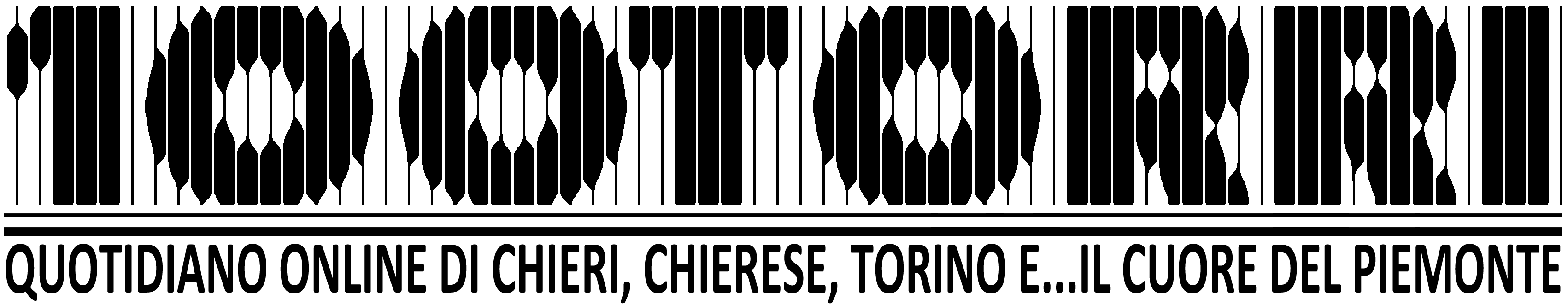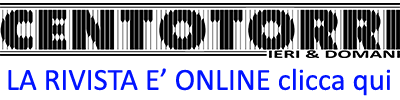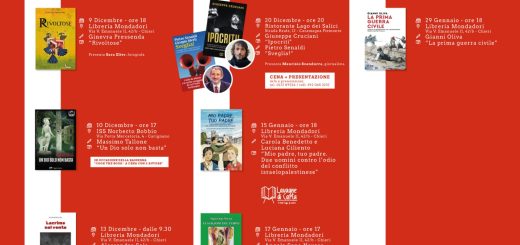1972, a Chieri il primo festival “I Giovani per i Giovani”Fu un evento di grande impatto, e portò molte polemiche. Ma fu anche, indubbiamente, un successo
di Alessandra Lunghi
Chieri non ha (e non ha mai avuto) un vero teatro pubblico: eppure, trent’anni fa, nel giugno 1972, diventò all’improvviso (o quasi) un importante punto di riferimento per il teatro sperimentale e per un po’ tutta l’avanguardia culturale.
Alla conferenza stampa dell’8 giugno 1972 tenutasi al Park Hotel, l’allora assessore all’istruzione di Chieri, Giovanni Salerno, presentò ufficialmente il Festival “I giovani per i giovani”, rassegna sperimentale di Teatro, Cinema, Musica e arti dell’Espressione. Erano presenti, oltre ai giornalisti, alle autorità cittadine e agli esponenti della cultura e della scuola chierese, Rolando Picchioni, principale patrocinatore dell’evento. In veste di assessore provinciale, egli aveva pianificato, d’intesa con il Teatro Stabile di Torino, l’“operazione decentramento”, una distribuzione delle attività teatrali nel territorio della provincia. In tono minore si era tentata una prima esperienza a Moncalieri nel ‘71, subito naufragata per problemi amministrativi; quindi si puntarono le carte su Chieri con un’iniziativa senza precedenti e di risonanza nazionale. La scelta fu in parte casuale, in parte motivata da una serie di vantaggi che la città presentava: il valore paesaggistico, la vivacità dimostrata in quegli anni e soprattutto la collaborazione dinamica dell’amministrazione comunale, elementi che costituivano “humus” adatto a far attecchire un discorso culturale impegnativo.
“ C’era l’ambizione di fare della città una piccola Avignone e in effetti si trasformò per alcuni anni almeno in una Spoleto piemontese”- ricorda Piero Crivellaro, allora addetto all’ufficio stampa del Festival e attualmente presso il Centro Studi del teatro Stabile
“ Negli anni a ridosso della rassegna, Guido Burzio, funzionario dell’Ufficio Cultura del Comune e braccio destro dell’assessore Salerno, aveva pilotato la partecipazione di una squadra di giovani chieresi, dieci ragazzi e dieci ragazze capeggiati da Laura Berruto, alla trasmissione televisiva “Come quando fuori piove”, in onda la domenica pomeriggio. I giovani vinsero ben sei volte di seguito, divenendo Campionissimi tra la fine del ’71 e l’inizio del ‘72. Ciò non fu la causa diretta della scelta di Chieri come sede del Festival, ma creò un terreno di aspettative di grandi eventi e diede un impulso dinamico all’amministrazione comunale, che divenne particolarmente propensa a promuovere attività innovative”- prosegue Crivellaro – “ Io divenni collaboratore culturale del Corriere proprio in seguito alla trasmissione e insieme a Gianni Giacone, anch’egli addetto all’ufficio stampa e collaboratore di Cronache Chieresi, e all’Ufficio Cultura costituimmo la squadra che seguì lo svolgimento della manifestazione”.
Come sostenne Picchioni, lo scopo del Festival era introdurre un nuovo concetto di cultura, la quale da monopolio e privilegio di pochi doveva diventare servizio per la crescita dell’individuo e occasione di comunicazione. Il progetto non voleva essere soltanto uno sporadico episodio sperimentale, ma aveva l’ambizione di perdurare nel futuro come appuntamento fisso del calendario chierese. E infatti proseguì fino al ’75 prima di essere abbandonato. La sua portata è resa evidente non soltanto dalla collaborazione tecnica dello Stabile, ma soprattutto dalle personalità che costituirono il Comitato Artistico, il cui compito era di segnalare le compagnie teatrali, compilando il cartellone della kermesse teatrale. Ne facevano parte Giuseppe Bartolucci, delegato della direzione del Teatro Stabile, Alberto Blandi, critico della Stampa, Guido Boursier, critico della Gazzetta del Popolo e in seguito cronista teatrale della RAI, Nino Ferrero dell’Unità, Augusto Romano dell’Avvenire.
Le proposte avanzate dal Comitato comprendevano le voci più convincenti e originali del Teatro d’Avanguardia dell’epoca: registi come Mario Ricci, Gian Carlo Nanni, Memè Perlini, Carlo Cecchi, Giuseppe Bartolucci: nomi che hanno scritto la storia del teatro contemporaneo. Ma negli anni ‘70 l’avanguardia era ancora relegata nelle cantine e, come affermò Picchioni, “ é una rassegna pericolosa, unica nel suo genere, che vuol dar fiato alla voce del teatro finora costretto ad un ruolo di minoranza, fuori della cultura codificata e privo della verifica di un pubblico popolare”: l’Assessorato all’istruzione della Provincia e il Comune di Chieri compirono un passo temerario, rompendo la tradizionale linea di sabotaggio da parte del teatro ufficiale e rischiando un grosso insuccesso.
Come per ogni novità d’impatto, non mancarono diffidenza e in alcuni casi brusche reazioni da parte della cittadinanza. “L’impressione generale fu di una città ostile e come minimo indifferente alle proposte, anche perchè era priva degli strumenti e della sensibilità necessari per assistere a spettacoli impegnativi e stravaganti. Malgrado ciò l’interesse manifestato da un certo mondo culturale di Torino compensò adeguatamente le reazioni negative”. Il panorama descritto da Crivellaro è confermato da quanto sostenne Graziano Camporese in un articolo comparso su Cronache Chieresi: “ Chieri ha una vita culturale assente…Manca l’interesse culturale come fatto collettivo…Manca la comunicazione sociale perchè non ci sono le strutture in cui possa avvenire e i luoghi d’incontro sono disertati. Il Festival forse risveglierà con un urto violento … Ma sarà un episodio isolato?…”.
Grande fu invece il sostegno della stampa locale – “ Il mio ruolo era differente da quello di Giacone. I redattori di Cronache Chieresi erano molto entusiasti della manifestazione , anche perchè alcuni di loro erano direttamente coinvolti nell’organizzazione degli spettacoli, mentre io mi ritrovavo a dover persuadere un pubblico più diffidente. Ma ebbi ugualmente tutto lo spazio che serviva per parlare del Festival.”
(1-continua)