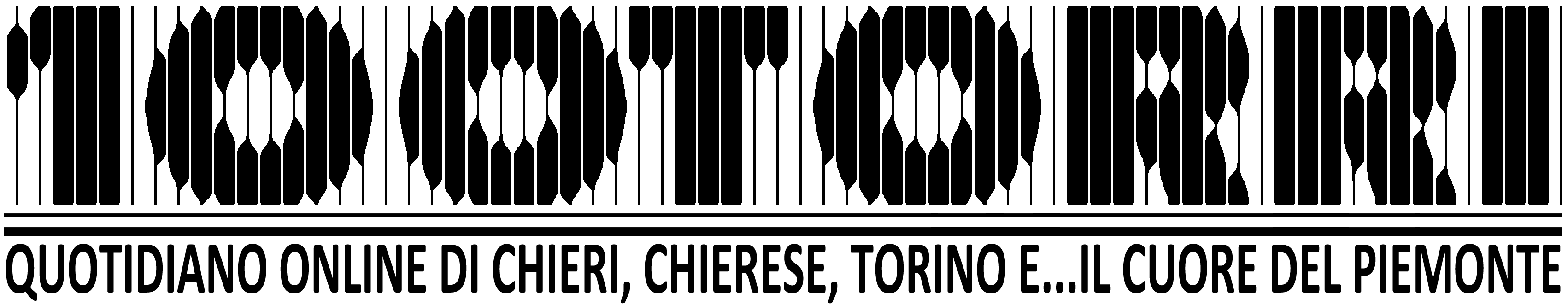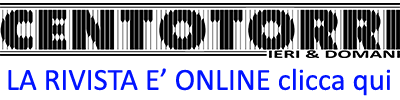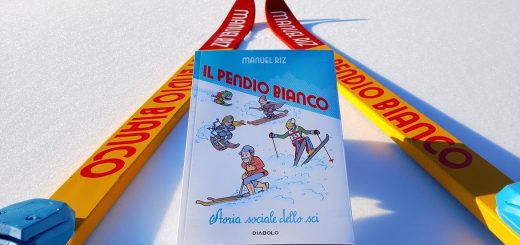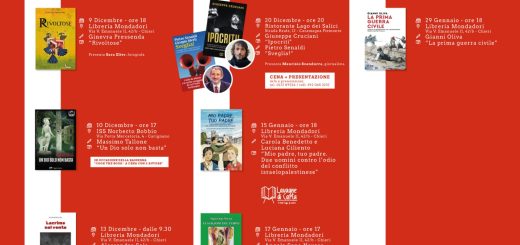CHIERI: MUSICA IN CORTE, APPUNTAMENTI DI QUALITA’
GLI ALBORI DELLA POLIFONIA-
 L’Accademia dei Solinghi ha proposto una serata davvero stimolante dedicata alla nascita della polifonia le cui prime fonti si attestano intorno al 900 quando in un trattato anonimo della Francia settentrionale sono riportate le prime informazioni su questa pratica consistente nel sovrapporre a una melodia desunta dal repertorio gregoriano (vox principalis) a una seconda voce (organalis) a distanza intervallare di quarta o di quinta procedente per moto contrario. L’arte polifonica, iniziata nel primo Cinquecento e durata fino al primo trentennio del Settecento, trovò la propria forma musicale nel genere profano connotato da un profondo lirismo e dalla predilezione del testo poetico. E’ il caso dell’inizio della serata con il brano Ininterrotte speranze dal Settimo Libro dei Madrigali dove Monteverdi introduce elementi di rottura con le forme tradizionali, seguendo così un’evoluzione nella direzione del genere del concerto. Il brano “Disserratevi abissi” dall’opera in un prologo e tre atti intitolata L’Argia (Innsbruck, 1655) di Antonio Casti, sviluppa una trama contorta, piena di tradimenti e di scambi d’identità, ruota intorno alle disavventure amorose di Seliino inseguito dalla moglie abbandonata la principessa Argia., E’ stato proposto anche un esempio di polifonia a due strumenti: la Sonata in la minore da Pièces des violes V Livre di Marin Marais che diede un notevole sviluppo alla viola da gamba, attivo alla corte di Luigi XIV°. Giovanni Battista Fasolo . frate conventuale astigiano e deceduto come titolare della cappella musicale del duomo di Monreale in Sicilia. Il brano Se l’ombra marina è tratto dalla raccolta di Arie spirituali, morali e indifferenti op. 9 . Il testo è un dialogo tra l’Angelo, l’Anima e il Demonio. Un esempio di squisita melodia e testimonianza della moda dilagante nel primo Seicento di adattamenti di testi drammatici. Non poteva mancare Vivaldi con il brano Piango gemo il cui testo è di autore ignoto. Chiusura affidata a un pezzo dalla raccolta di canzoni Orpheus Britannicus di Henry Purcell pubblicata postuma in due volumi. Maiuscola la prova dei due controtenori Angelo Galeano e Gianluigi Ghiringhelli diverse per timbro e colore, mantenendosi sempre differenti l’una dall’altra dal punto di vista melodico e anche ritmico con grande attenzione ai principi armonicI. Eleonora e Virginia Ghiringhelli (viole) accompagnano le voci in modo dolce, conferendole temperamento e intensità espressiva. Il tutto governato con la consueta maestria da Rita Peiretti (clavicembalo) che non rinuncia a mettere a fuoco il respiro del fraseggio e i dettagli. Serata all’insegna di un franco successo da parte di un pubblico ormai fideizzato.
L’Accademia dei Solinghi ha proposto una serata davvero stimolante dedicata alla nascita della polifonia le cui prime fonti si attestano intorno al 900 quando in un trattato anonimo della Francia settentrionale sono riportate le prime informazioni su questa pratica consistente nel sovrapporre a una melodia desunta dal repertorio gregoriano (vox principalis) a una seconda voce (organalis) a distanza intervallare di quarta o di quinta procedente per moto contrario. L’arte polifonica, iniziata nel primo Cinquecento e durata fino al primo trentennio del Settecento, trovò la propria forma musicale nel genere profano connotato da un profondo lirismo e dalla predilezione del testo poetico. E’ il caso dell’inizio della serata con il brano Ininterrotte speranze dal Settimo Libro dei Madrigali dove Monteverdi introduce elementi di rottura con le forme tradizionali, seguendo così un’evoluzione nella direzione del genere del concerto. Il brano “Disserratevi abissi” dall’opera in un prologo e tre atti intitolata L’Argia (Innsbruck, 1655) di Antonio Casti, sviluppa una trama contorta, piena di tradimenti e di scambi d’identità, ruota intorno alle disavventure amorose di Seliino inseguito dalla moglie abbandonata la principessa Argia., E’ stato proposto anche un esempio di polifonia a due strumenti: la Sonata in la minore da Pièces des violes V Livre di Marin Marais che diede un notevole sviluppo alla viola da gamba, attivo alla corte di Luigi XIV°. Giovanni Battista Fasolo . frate conventuale astigiano e deceduto come titolare della cappella musicale del duomo di Monreale in Sicilia. Il brano Se l’ombra marina è tratto dalla raccolta di Arie spirituali, morali e indifferenti op. 9 . Il testo è un dialogo tra l’Angelo, l’Anima e il Demonio. Un esempio di squisita melodia e testimonianza della moda dilagante nel primo Seicento di adattamenti di testi drammatici. Non poteva mancare Vivaldi con il brano Piango gemo il cui testo è di autore ignoto. Chiusura affidata a un pezzo dalla raccolta di canzoni Orpheus Britannicus di Henry Purcell pubblicata postuma in due volumi. Maiuscola la prova dei due controtenori Angelo Galeano e Gianluigi Ghiringhelli diverse per timbro e colore, mantenendosi sempre differenti l’una dall’altra dal punto di vista melodico e anche ritmico con grande attenzione ai principi armonicI. Eleonora e Virginia Ghiringhelli (viole) accompagnano le voci in modo dolce, conferendole temperamento e intensità espressiva. Il tutto governato con la consueta maestria da Rita Peiretti (clavicembalo) che non rinuncia a mettere a fuoco il respiro del fraseggio e i dettagli. Serata all’insegna di un franco successo da parte di un pubblico ormai fideizzato.
UN ESEMPIO DI EQUILIBRIO E RISPETTO.-
Gradita sorpresa con il sigillo dell’alto livello qualitativo del programma Ed erba l’armonia per questa valle, versetto dal canto Il passero solitario di Leopardi. Ospite della rassegna Musica in corte l’ensemble L’Archicembalo nato un quarto di secolo fa ad opera del violinista Michela Bianchi secondo la prassi dell’epoca su strumenti originali dal barocco al primo classicismo .Ha fatto tesoro delle esperienze di grandi virtuosi come Harnoncourt o Koopmam che hanno condotto l’ensemble nella direzione di precisi risultati circa timbrica, fantasia, equilibrio e, carattere mai disgiunti dal rispetto della partitura. Il concerto non poteva che prendere avvio nel nome di Vivaldi, uno dei baricentri del repertorio del gruppo., con la Sonata in re minore n. 3 dall’opera 12 dedicata al re Federico IV° di Danimarca. Stimolante il confronto tra Haendel (Sonata in fa maggiore op. 1 n. 12) e J.S. Bach (Sonata in sol maggiore BWV 1021): il primo sapiente autore che guarda al presente, avido di novità: il secondo rappresenta l’anima mistica del barocco. Domenico Scarlatti scrisse 559 Sonate per tastiera e un secondo strumento. La scelta è caduta sulla Sonata in mi minore K. 81 dal catalogo Kirkpatrick (1953) che costituisce uno dei cinque unicum per quanto riguarda il trattamento della dissonanza (risparmio al lettore la dotta musicologia). Contemporaneo di Bach e Haendel è Georg Philip Telemann (Sonata in la minore op. 41 a tre) che ebbe una lunga parabola creativa fino a toccare la soglia del classicismo. Non è mancata la sorpresa con Paolo Benedetto Bellinzani, deceduto nel 1757, con la Sonata op. 3 n. 2 (variazioni sopra La Follia), pezzo brillante, a tratti energico, fantasioso che ha stimolato l’orecchio degli ascoltatori che sembravano non abbandonare la chiesa di San Filippo. Michele Bianchi (violino),Claudio Merlo (violoncello) e Daniela Demicheli(clavicembalo)=: tre eccellenti musicisti che hanno offerto un barocco non ingessato, ma incisivo, mosso. Veramente unici per equilibrio emotivo senza lasciarsi condizionre da preziosismi superflui. Applaudi convinti con rilascio dei due bis.
EDOARDO FERRATI