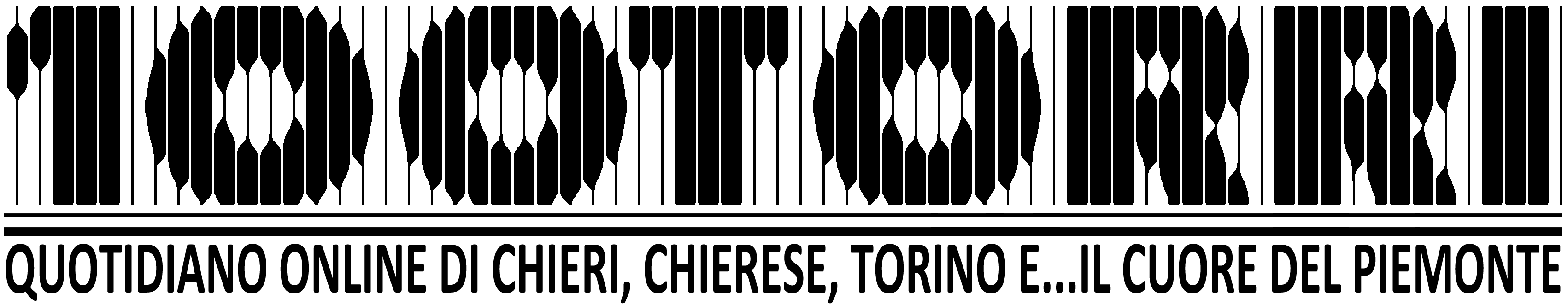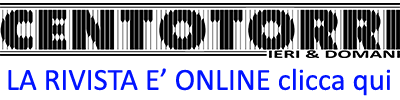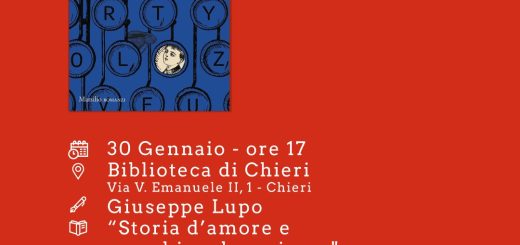CHIERI. SORPRESE DI ARTE E DI STORIA – Cristiani ed Ebrei nella Chieri dell’Ottocento: non solo tensioni

Il ghetto di Chieri
Durante il secolo XIX la comunità ebraica chierese era diventata molto numerosa, arrivando a contare 28 famiglie, circa 170 persone. Sui rapporti fra la maggioranza cristiana e la minoranza ebraica è stato scritto molto, sottolineandone le tensioni. Ma c’era anche dell’altro. È nota, per esempio, la stima che legava lo studioso G. B. Gioacchino Montù con la comunità ebraica. Montù era un esperto della lingua ebraica che, a detta degli stessi intellettuali ebrei, conosceva perfettamente. È’ anche noto che, nonostante i divieti vigenti, qualche donna cristiana prestava servizio presso ricche famiglie ebree. Il già citato Montù racconta che nei giorni della festa della Madonna delle Grazie la separazione fra le due comunità veniva meno: molti Ebrei, soprattutto le donne, amavano entrare in Duomo ad ammirarne gli addobbi. E nel giorno della festa musicisti ebrei suonavano nel complesso che accompagnava la liturgia. Ma accadeva anche il contrario. Nel novembre del 1822, ad esempio, l’ebreo Todros organizzò un concerto filarmonico presso la sua “vigna” situata dalle parti del cimitero. Il concerto fu seguito da un ballo al quale parteciparono persone sia cristiane che ebree: “… Tota Rossi ballò con Todros – riferisce il Montù – . Federico Gayot con una ebrea, Anastasia con Ramello ecc. ecc.”. E la sera del 2 agosto 1844, quando venne inaugurato il nuovo tempio israelitico, “…tutti i curiosi della città in folla a visitarlo… Cantori fatti venire da Torino e anche un corpo di Chieri”. Dopo la soppressione degli Ordini religiosi, che anche a Chieri determinò la svendita e spesso la scomparsa di chiese monumentali e monasteri, il sindaco ebreo David Levi si distinse fra tutti per tolleranza e comprensione, forse anche per merito di sua moglie Sefora, che il Montù definisce “… donna cui non mancava che il Battesimo per essere tutta cristiana e piena di vera carità verso qualunque povero”. Nel 1811 partecipò con 1000 franchi alla colletta indetta per convincere Porati, l’acquisitore della juvarriana chiesa di Sant’Andrea, a non demolirla. Nessun altro, oltre a lui, si sottoscrisse, nemmeno fra i cristiani. Così la monumentale chiesa andò distrutta. Negli stessi anni, un’altra chiesa destinata alla demolizione era quella della Consolata. Quando la chiesa fu sigillata, il rettore padre Seghini si rese conto con grande rammarico che il SS. Sacramento era rimasto nel tabernacolo. David Levi di nascosto tolse i sigilli e li rimise dopo che il sacerdote ebbe consumato le Ostie consacrate. Lo stesso Levi volle che nella chiesa di San Filippo, diventata di proprietà del Comune insieme all’ex convento dei Filippini, si conservasse il SS. mo Sacramento e davanti ad Esso ci fosse sempre la lampada accesa. Il Montù aggiunge che quando celebrava matrimoni o altre funzioni in Municipio, Levi fu sempre molto rispettoso, a differenza dei vari Magagallo, Goffi, Cornaglia e Tosco che erano soliti sbeffeggiare gli ecclesiastici.
Antonio Mignozzetti