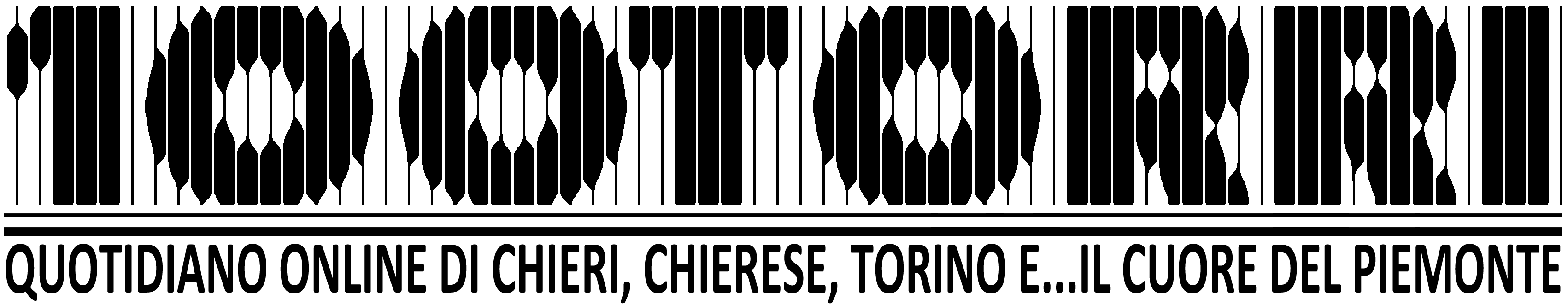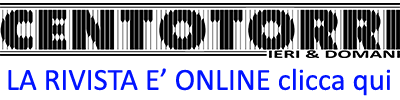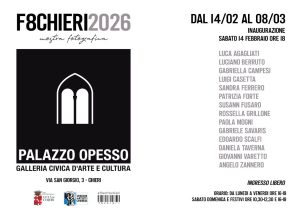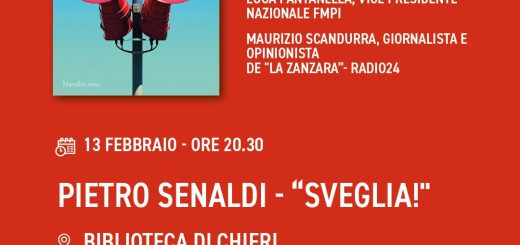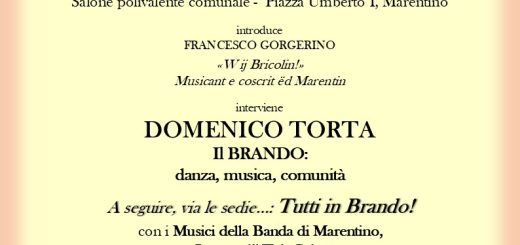CHIERI. SORPRESE DI ARTE E DI STORIA – La movimentata storia del convento di San Domenico

La facciata del convento di San Domenico.
Nella sua esistenza di quasi otto secoli, il convento di San Domenico a Chieri ha vissuto le più incredibili vicissitudini.
1802: anche sul di esso, come sugli altri conventi e monasteri chieresi, si scatena la bufera napoleonica. Ma mentre gli altri vengono svenduti, quello domenicano viene destinato ad accogliere i religiosi anziani e malati degli altri Ordini soppressi.
1821: passata la tempesta, il convento riapre le porte alla comunità domenicana.
Ma è una tranquillità che dura pochi decenni: nel 1855, quando per le leggi Rattazzi gli Ordini religiosi contemplativi e mendicanti vengono di nuovo soppressi, il convento di San Domenico viene requisito a favore del Demanio.
Nel 1857 lo acquista per 68.000 lire l’Amministrazione Comunale di Chieri che vi sistema il Collegio-Convitto.
Nel 1867 lo cede all’esercito e trasferisce il Collegio-Convitto nel palazzo Tana. L’esercito, però, dopo solo un anno lo lascia libero. Cosa della quale approfitta il sacerdote torinese don Giovanni Cocchi, il quale ne ottiene dal Comune l’uso gratuito per aprirvi una comunità di ragazzi “difficili”, una specie di “riformatorio”. Ma solo due anni dopo il Comune, bisognoso di soldi, dà lo sfratto a don Cocchi e alla sua comunità (che si trasferiscono a Bosco Marengo, in provincia di Alessandria) e per fare cassa mette all’asta l’ex convento. Se lo aggiudicano per 45.550 lire quattro sacerdoti, con lo scopo di cederlo ai Domenicani per consentire loro di tornare nella loro antica sede. Ma nel vendere il complesso il Comune si riserva il diritto di poter utilizzare la chiesa di San Domenico in certe occasioni che richiedono uno spazio particolarmente ampio, come il 4 giugno, festa dello Statuto, quando viene fatta la premiazione degli studenti delle scuole pubbliche. Una servitù, questa, che con il passare degli anni per i Frati diventa sempre più indigesta, tanto che a più riprese cercano di liberarsene. Ma senza mai riuscirci, perché sembrava cosa umiliante che il Comune, ente laico (in realtà laicista), rinunciasse ad un suo diritto a favore di un ente religioso.
Dal 1894, però, il Comune una concessione la fa: accetta di limitare l’utilizzo della chiesa alle sole navate, e di rinunciare al Presbiterio e al Coro, cioè alle zone rivestite di maggiore sacralità. Si va avanti così per altri trenta anni.
Nel giugno del 1925, finalmente, ormai in pieno regime fascista, riconoscendo l’inopportunità dell’uso di un luogo consacrato per uno scopo profano, e visto che ormai per la premiazione scolastica sono disponibili altri ambienti più adatti, come il Politeama Chierese e il Politeama Margherita, il Commissario Prefettizio Nicola Rivela rinuncia a quell’anacronistico diritto. L’accordo viene firmato il 5 settembre dello stesso anno. Accordo che, comunque, ai Frati costerà un risarcimento di 10.000 lire
Antonio Mignozzetti