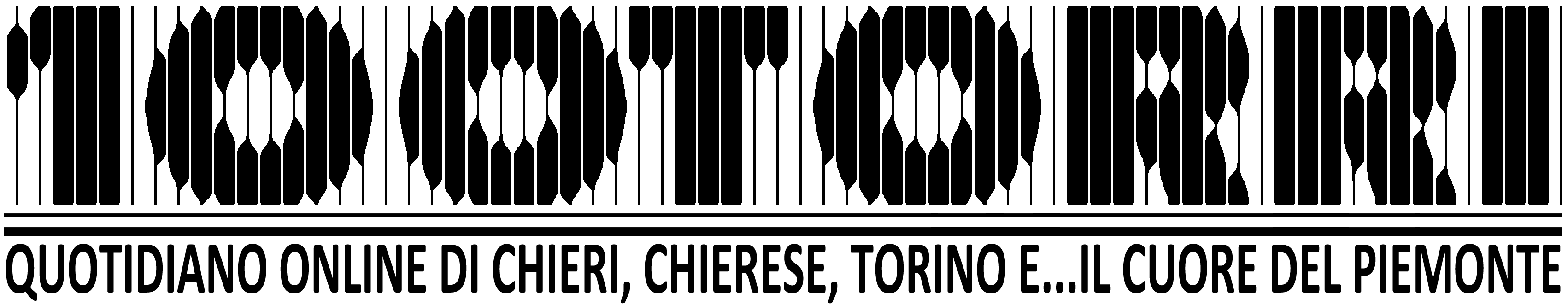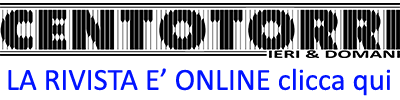Chierese d’adozione, ha perpetuato il ricordo delle opere del padre
di Valerio Maggio

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Sabato 14 giugno a Torino, nell’ottantesimo anniversario della morte, il Centro Studi Piemontese, ha organizzato un incontro commemorativo in ricordo di Nino Costa: “il poeta delle nìvole”. Nato a Torino il 28 giugno del 1886, dopo aver frequentato il liceo classico Cavour, Costa si laurea in Lettere e in Medicina Veterinaria. Subito dopo trascorre alcuni periodi a Parigi e – in attesa di svolgere la professione di bancario presso la Cassa di Risparmio di Torino per tutta la vita – insegna in alcuni licei torinesi.
Con lo pseudonimo di Mamina pubblica le sue prime poesie in lingua piemontese sul settimanale Birichin; successivamente darà alla stampa le raccolte in versi: Mamina (1922), Sal e Pèiver (1924), Brassabòsch (1928), Fruta madura (1931), Poesie religiose piemontèise (1934), Ròba nòstra (1938). L’ultimo suo lavoro, intitolato Tempesta, verrà invece pubblicato postumo nel 1946 a pochi mesi dalla sua morte, avvenuta il 5 novembre 1945, poco dopo la prematura scomparsa del figlio Mario caduto – a soli diciannove anni in Val Chisone, nei pressi del monte Genevry – durante un’azione partigiana mentre, da solo, nell’intento di aprire una via di salvezza ai propri compagni, si lanciava all’assalto di un ‘fortino’ rimanendo ucciso dal fuoco nemico. Il compito di perpetuare il ricordo del papà – nel momento in cui la critica lo riconoscerà come «poeta della nostra terra (…) capace di cantare le nostre virtù, le nostre glorie, la nostra tenacia nel lavoro, la nostra razza libera e testarda con un dialetto ora dolce ora aspro, ora gioioso ora malinconico: ma sempre meravigliosamente eloquente e semplice», ma anche del fratello entrato a far parte della Resistenza «con la benedizione del padre» – toccherà alla figlia Celestina (avrebbe compiuto cent’anni quest’anno) chierese di adozione. Conosciutissima per essere stata, per oltre un ventennio, direttrice didattica delle nostre scuole elementari contribuisce a fondare la locale Università della Terza Età.
Essere la figlia di Nino implicava per lei assumersi la responsabilità di perpetuare il ricordo del padre attraverso la divulgazione sia delle opere che del lascito culturale a lui legato. In un’intervista rilasciata nel 1973 al giornalista Girolamo Mangano sottolineava come il padre abbia sempre sperato in un ‘mondo migliore’ contraddicendo con ciò quanti lo volevano inserire tra i poeti crepuscolari “perché i crepuscolari – sottolineava – non hanno speranza nella vita mentre lui pur dicendo ‘ogni giorno un sogno se ne va, una delusione ci schiaffeggia’ si riprendeva affermando subito dopo ‘siamo bisce per tutta la vita ma c’è sempre un giorno in cui siamo allodole’”. Le testimonianze ci raccontano come, in qualità di direttrice didattica, abbia saputo «coniugare autorità e senso di responsabilità senza mai cadere nell’autoritarismo ispirandosi al modello famigliare» che li voleva “sì capi ma a modo nostro”. Precisava: “Capo lo era papà pur affermando ‘l’operaio è mio fratello’. Capo lo era mio fratello partigiano, a cui i fascisti strapparono gli occhi e i denti prima di ucciderlo. Capi i nostri antenati: erano Conti. Ma mio padre fece cancellare il titolo nobiliare dallo Stato Civile”.