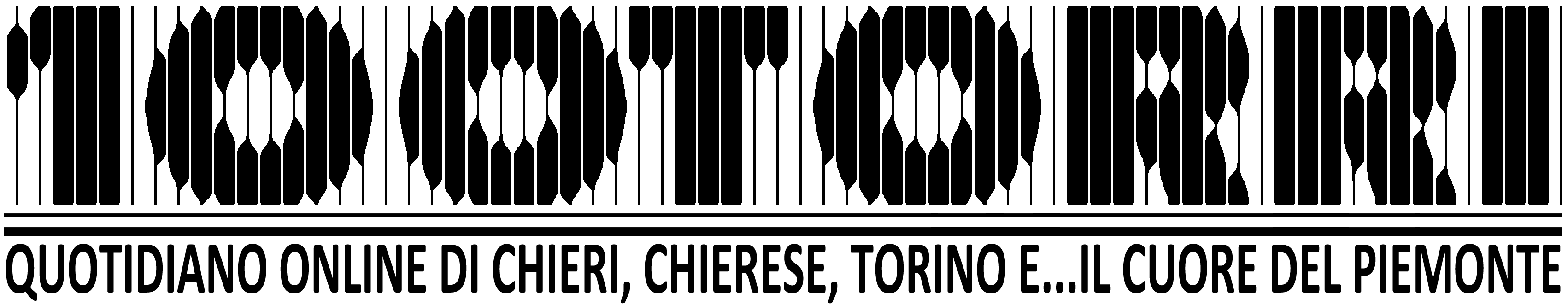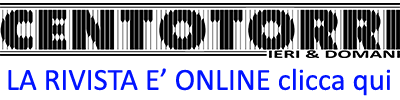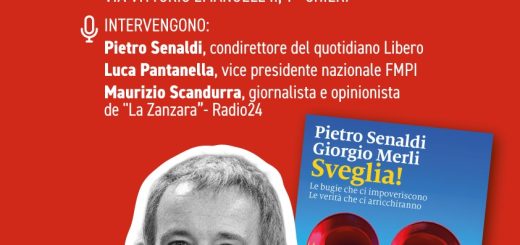CHIERI. CURIOSITA’ DI ARTE E STORIA – Il “Palazzo Diverio” o “della Consolata”: immenso e dimenticato
 Percorrendo via San Giorgio in piazza Mazzini, e lasciata sulla sinistra via della Consolata, si costeggia un piccolo parco dietro al quale si intravede un grande palazzo costruito con mattoni a vista. Nonostante la sua imponenza, l’edificio, di proprietà del Comune, è quasi ignorato e totalmente inutilizzato. Si chiama “Palazzo Diverio” o “Palazzo della Consolata”: “ Diverio” perché fu donato al Comune dal chierese Michele Diverio; “ della Consolata” perché costruito dai Padri Barnabiti che gestivano la vicina chiesa di Maria SS. ma Consolata.
Percorrendo via San Giorgio in piazza Mazzini, e lasciata sulla sinistra via della Consolata, si costeggia un piccolo parco dietro al quale si intravede un grande palazzo costruito con mattoni a vista. Nonostante la sua imponenza, l’edificio, di proprietà del Comune, è quasi ignorato e totalmente inutilizzato. Si chiama “Palazzo Diverio” o “Palazzo della Consolata”: “ Diverio” perché fu donato al Comune dal chierese Michele Diverio; “ della Consolata” perché costruito dai Padri Barnabiti che gestivano la vicina chiesa di Maria SS. ma Consolata.
I Chierici Regolari di San Paolo (detti anche Barnabiti dalla loro prima casa madre, la chiesa milanese di San Barnaba) si stabilirono a Chieri nel 1624, in uno stabile di via San Giorgio concesso loro dal conte Francesco Girolamo Vagnone dei signori di Trofarello. Inizialmente officiarono una piccola cappella, dedicata alla Consolata, costruita da certo Giovanni Francesco Balma. A metà del Settecento sostituirono la cappella con una chiesa più grande progettata dal frate barnabita Pomei. E poiché la loro principale attività era l’insegnamento, negli anni 1750-1759, su progetto degli architetti torinesi Carlo Emanuele Rocca e Sebastiano Riccati, costruirono un grande collegio che rivaleggiò con quello dei Gesuiti: il palazzo del quale stiamo parlando. .
Nel 1802, in seguito alla politica religiosa di Napoleone, come altre congregazioni religiose anche la comunità barnabita venne soppressa e i rispettivi edifici messi in vendita. La chiesa venne acquistata dal medico chierese Lupo, che nel 1833 la demolì per ricavarne materiale da costruzione. Il collegio, vinto all’asta dal torinese Ignazio Morelli, passò per diverse mani fino ad arrivare in quelle dei coniugi Michele e Margherita Nel. Costoro lo lasciarono in eredità al nipote Michele Diverio, che nel 1907 lo donò al Comune. Ma lo donò ponendo delle condizioni: «É fatto obbligo al Municipio legatario di destinare lo stabile a caserma di presidio di truppa, sempreché tale antico desiderio del legatario e della cittadinanza chierese possa essere esaudito. Se dopo esperite le pratiche occorrenti (durante le quali il Municipio godrà di tutti i frutti dell’immobile) non fosse assolutamente possibile ottenere il presidio militare, lo stabile dovrà in tutto od in parte essere adibito ad edifizio scolastico laico, con preferenza ad un istituto a tipo professionale, più specialmente a vantaggio dell’arte tessile chierese. (Qualora poi non fosse possibile nemmeno l’impianto dell’Istituto scolastico, il Municipio dovrà destinare lo stabile o parte di esso a ricovero laico di poveri vecchi inabili al lavoro o ad altra opera di carità amministrata da un presidente e sei consiglieri nominati dal Consiglio Comunale ».
Desiderio del Diverio, quindi, era che il suo palazzo venisse impiegato a fini o militari, o scolastici o assistenziali. Cercando di rispettarne le disposizioni, il Comune inizialmente vi ospitò le scuole comunali. Trasferite queste negli ex conventi di San Filippo e Sant’Antonio, vi sistemò un ambulatorio pediatrico ed ostetrico. Nel 1934, una delibera del Podestà Luigi Mussino ne fece la sede di un centro della recentemente istituita Opera Nazionale Protezione Maternità e Infanzia (ONMI): al piano seminterrato c’erano la cucina, la lavanderia e l’impianto di distribuzione dell’acqua calda; al pianterreno il refettorio per 36 donne e 36 bambini, gli uffici amministrativi e i bagni; al primo piano le sale per le culle, i consultori ostetrico e pediatrico, le camere d’isolamento e i bagni. Il centro era dotato di riscaldamento a termosifone, di un impianto per l’acqua calda e fredda, di un montacarichi e disponeva di ampi spazi aperti.
Dopo la guerra il palazzo ha conservato la sua vocazione sanitaria, ospitando gli uffici e gli ambulatori dell’Unità Sanitaria Locale, fino a quando questa non si è dotata di strutture proprie. Una volta rimasto vuoto, il Comune ha tentato più volte di liberarsene. Ma fino ad ora tutti i tentativi di venderlo sono risultati vani.
Antonio Mignozzetti