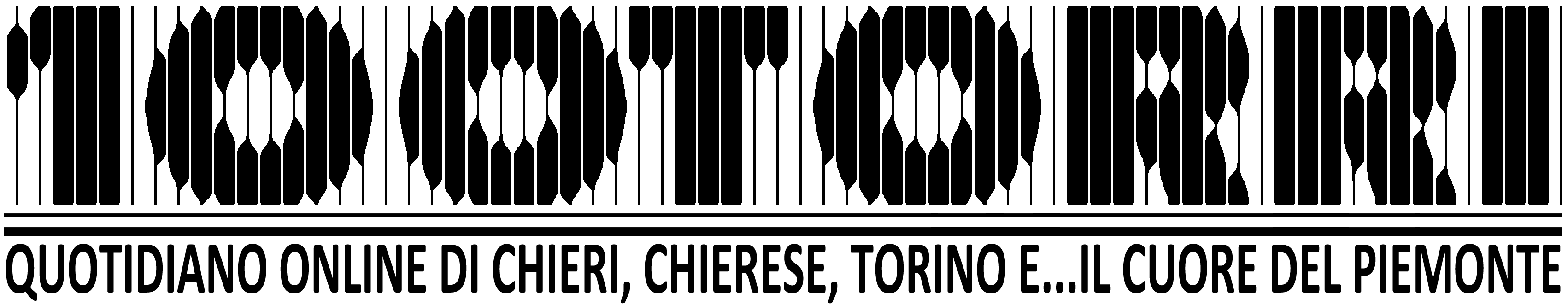L’ALTRO SCHERMO, il cinema al cinema- Il Van Gogh di Schnabel: lo sguardo inquieto sull’eternità
 Che Vincent Van Gogh sia il pittore più “pop” della storia, forse il primo dell’era moderna, molto prima che Andy Wharol nascesse, lo dimostrano, se ancora ce ne fosse bisogno, le file nelle sale dove viene proiettato il film di Julian Schnabel “Van Gogh – Sulla soglia dell’eternità”. Non si sa ancora se il fenomeno sia dovuto alla bravura del regista e dell’attore protagonista o al semplice richiamo che il nome dell’artista olandese costituisce per la cultura di massa che dal Novecento ai giorni nostri si muove sempre con le stesse dinamiche.
Che Vincent Van Gogh sia il pittore più “pop” della storia, forse il primo dell’era moderna, molto prima che Andy Wharol nascesse, lo dimostrano, se ancora ce ne fosse bisogno, le file nelle sale dove viene proiettato il film di Julian Schnabel “Van Gogh – Sulla soglia dell’eternità”. Non si sa ancora se il fenomeno sia dovuto alla bravura del regista e dell’attore protagonista o al semplice richiamo che il nome dell’artista olandese costituisce per la cultura di massa che dal Novecento ai giorni nostri si muove sempre con le stesse dinamiche.
Willem Dafoe è un Van Gogh molto più che credibile e la Coppa Volpi a Venezia non poteva che andare a lui. Il film si regge completamente sulla sua prova d’attore perché, diciamolo subito, Schnabel non aveva nessuna intenzione di far stare comodo lo spettatore raccontandogli la solita favoletta del pittore pazzo e incompreso. Questo è un film “sporco”, girato con inquadrature fuori fuoco, primi piani esagerati, con i volti catturati spesso parzialmente, tanto è stretta la camera sugli attori. Una tecnica a volte frenetica che può risultare a tratti sgradevole, con lunghi momenti di “nero” riempiti solo dalle parole di Van Gogh in forma di voce narrante fuori campo, ma se l’intenzione dell’autore era di guardare e far guardare con gli occhi di Vincent, ha scelto l’unico modo possibile.
Raccontare la pittura non è mai stato facile e non lo diventa improvvisamente solo perché il cinema è un’arte visiva: troppo evidente il contrasto dell’uso delle immagini e della luce, elemento, quest’ultimo, rincorso per tutta la sua breve vita da Van Gogh. Così Schnabel percorre un’altra via. Non racconta l’arte di Van Gogh attraverso una biografia cronologica, ma cerca di guardare e sentire attraverso gli occhi e il pensiero di Vincent.

File di spettatori in Sala Pastrone
Lo sguardo di Van Gogh si trasferisce così negli occhi dello spettatore che sicuramente ha bisogno di un po’ di tempo per capire le intenzioni di Schnabel ed entrare in sintonia con la recitazione “minima” e asciutta di Dafoe. Il soggetto del film non è incentrato quindi sulle opere famose che il pittore ci ha lasciato, ma sul modo in cui Van Gogh le ha pensate e “viste” prima di buttarle velocemente sulla tela, ispirato dalla natura e dalla luce. Il bisogno di immergersi totalmente nella natura lo portò ad Arles e nel film quello è il periodo centrale della vita dell’artista preso in considerazione. A margine il suo rapporto con Gauguin, con il fratello Theo e con i primi sintomi del suo disagio mentale. Ma Schnabel ancora una volta porta altrove lo sguardo, suggerendo allo spettatore una lucidità impossibile da capire e persino da concepire dalla società contemporanea a Van Gogh:
Sono un pittore perché è la sola cosa che so fare – dice Van Gogh-Dafoe nel film – perché il buon Dio mi avrebbe dato questo dono, per fare quadri brutti? Forse io dipingo per qualcuno che non è ancora nato”.
Il regista punta quindi a svelare la perfetta consapevolezza di sé e della forza della sua arte di Van Gogh. E accarezzando quest’idea vuole raccontare un altro pittore, non davvero incompreso dalla sua epoca, ma svelato ai più un attimo dopo rispetto al successo che avrebbe avuto se la sua vita non si fosse interrotta bruscamente. Non si sa se il suicidio si possa davvero mettere in dubbio, ma Schnabel prova a suggerire un’altra versione. Una versione che resta negli occhi dello spettatore oltre i titoli di coda.
(Visto in Sala Pastrone, Asti il 6 gennaio 2019).
Carmela Pagnotta